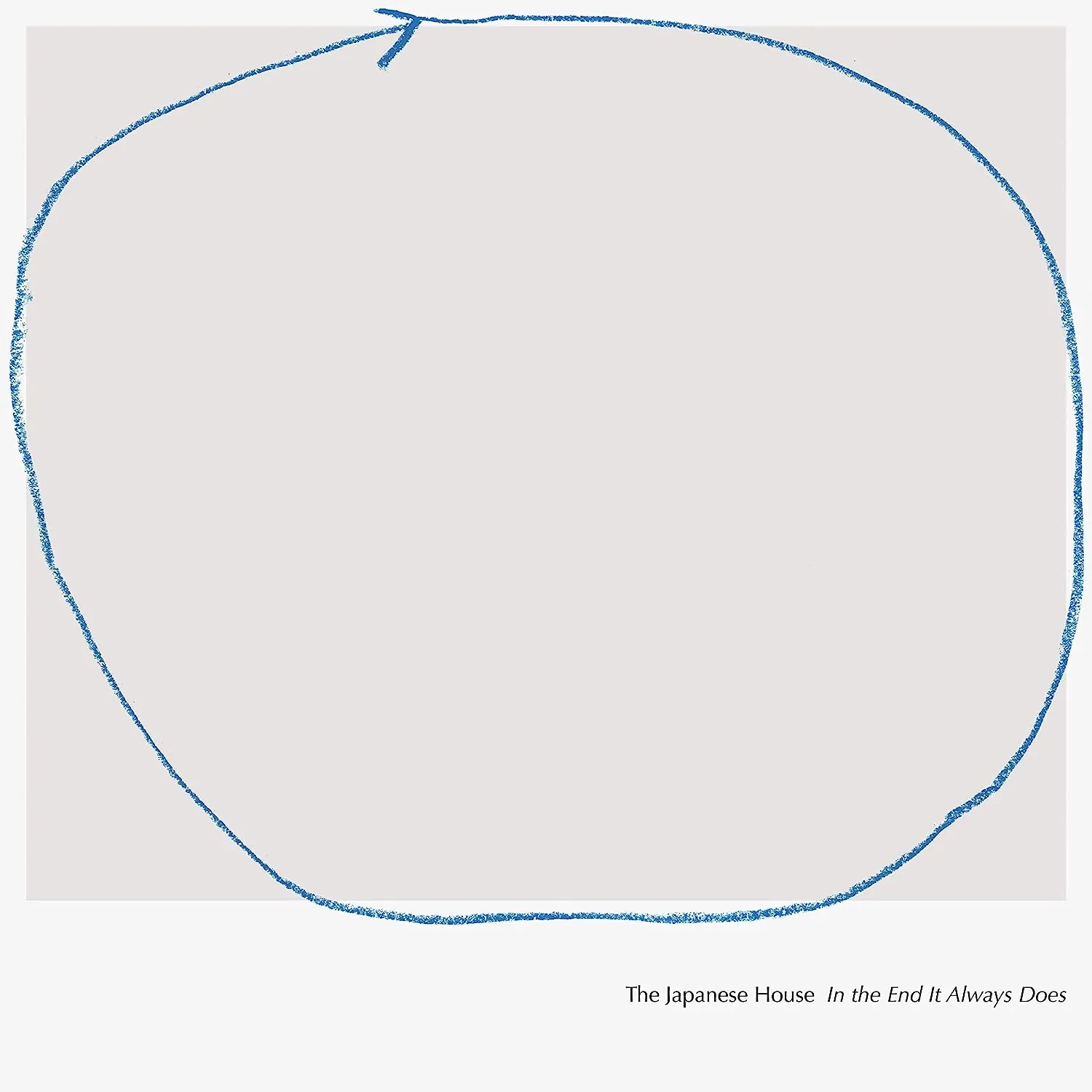The Japanese House
In the End It Always Does
Lo spazio espressivo dell’indie-pop, vicino e lontano dalla classifica, rappresenta uno dei luoghi più prolifici per l’espressività. Nonostante la sua posizione di genere di nicchia, la rosa di artisti che ne fanno parte è molto variegata e apprezzata anche a livello critico. Testi malinconici, introspettivi, traboccanti della personalità del suo esecutore, spesso legati a questioni – identità, senso di sé, amori e sentimenti difficili da sbrogliare – che risuonano da vicino con la comunità queer. Perfetta combinazione di queste qualità è Amber Bain, in arte The Japanese House, che si è fatta conoscere con il suo debutto Good At Falling nel 2019.
Ma se c’è un avversario temibile per questo genere sono i tropi nei quali questo si articola, e Bain, con In The End It Always Does, affronta faccia a faccia la minaccia del sophomore slump. Il risultato è un album sicuramente competente, ma di poco impatto nell’economia dello spazio nel quale si muove. Buono per il momento, ma forse non sufficiente a lunga durata.
Si vede il tentativo di Bain di creare un’identità sua nell’ambito dell’indie-pop; forse anche per distanziarsi dai comportamenti provocanti e bigotti del suo mentore, Matty Healy dei The 1975, che – si spera in forma di commiato – appare tuttavia nel singolo Sunshine Baby. E sopratutto di fare bene il suo lavoro, curando finemente il dettaglio lirico di ogni traccia e concludendo bene. Di One For Sorrow, Two for Joni Jones esiste peraltro una versione acustica e stripped back che, oltre a funzionare altrettanto bene con l’incerta sofferenza della traccia, mette in evidenza meglio di prima la bella voce della cantante. C’è persino una collaborazione con una collega, anzi delle colleghe: le MUNA, il cui membro Katie Gavin appare nella canzone Morning Pages, e aiutano per una volta a variegare la coloratura sonora.
In The End It Always Does non è un album di facile appeal. Persino più dei contemporanei del genere punta tutto sul testo e la sua ricchezza interpretativa. Il che porta a risultati di indubbia qualità, ma che penalizza l’esperienza di ascolto nel momento in cui non si ha a disposizione un portico silenzioso, un pomeriggio di tramonto senza far nulla o una stanza buia in cui goderselo piano piano. Sono cose che succedono nel genere, ma che qui succedono un po’ troppo.
Il che delude soprattutto perché i singoli strumenti di questa combinazione – a cominciare dalla voce di Bain, profonda e accattivante – sono validi ed eccellenti per raccontare la scoperta di sé. Le influenze sono chiare, dal cantautorato di Joni Mitchell all’esplorazione in salsa folk delle indigo girls, e sono interpretate con abbastanza riconoscibilità e comodità da aprire a scenari interessanti. La prospettiva di Bain è molto personale, ed è questo a rendere tracce come Boyhood, un’esplorazione cruda dell’assurdità del senso di sé come persona queer in un mondo ancora oggi chiuso e poco accogliente, molto più taglienti dopo più di un ascolto. Anche il secondo singolo Sad To Breathe, nella sua semplicità, comunica ottimamente il dolore della separazione.
Per motivi come questi è difficile criticare In The End It Always Does. È un racconto emotivo senza fronzoli, splendidamente onesto, immerso in una cornice sonora convenzionale che gli impedisce di spiccare come dovrebbe. Offrirà, tuttavia, pane per i denti degli amanti del suo genere, oltre che uno sguardo a quadri di vita vissuta di immenso valore.
The Japanese House
In the End It Always Does
Genre: Dream pop
Tracks:
- 1) Spot Dog
- 2) Touching Yourself
- 3) Sad to Breathe
- 4) Over There
- 5) Morning Pages
- 6) Boyhood
- 7) Indexical Reminder of a Morning Well Spent
- 8) Friends
- 9) Sunshine Baby
- 10) Baby Goes Again
- 11) You Always Get What You Want
- 12) One for Sorrow, Two for Joni Jones